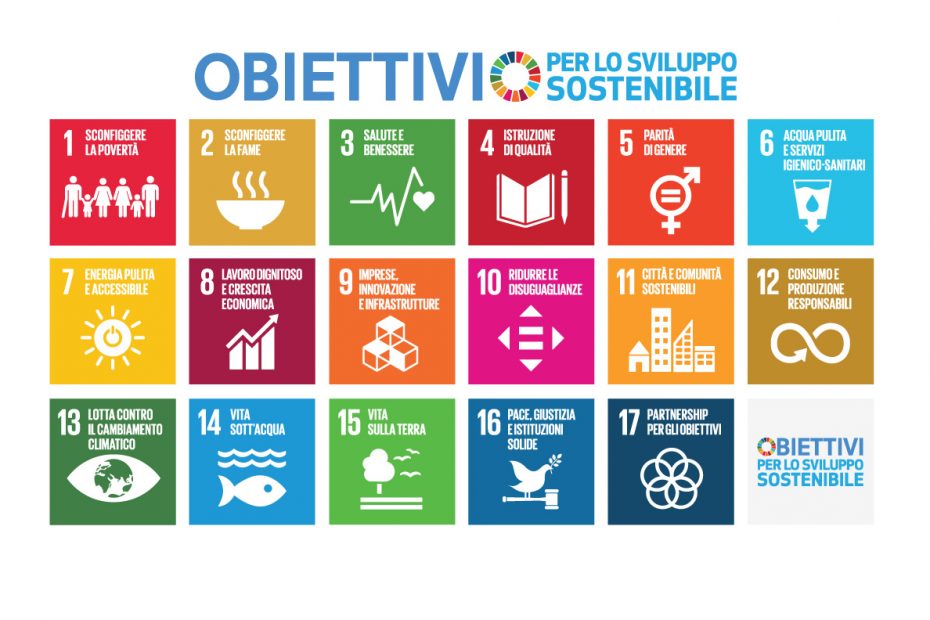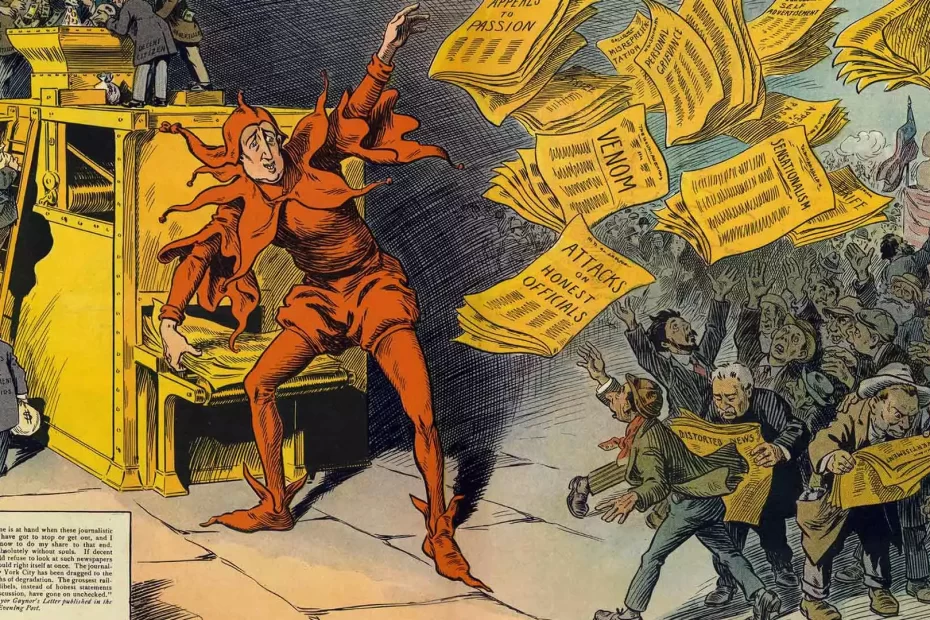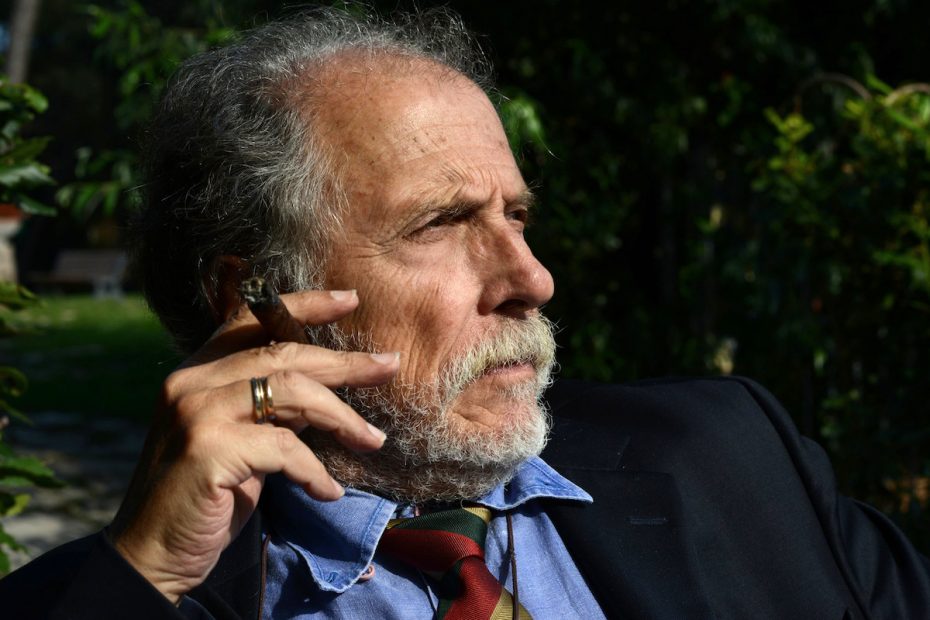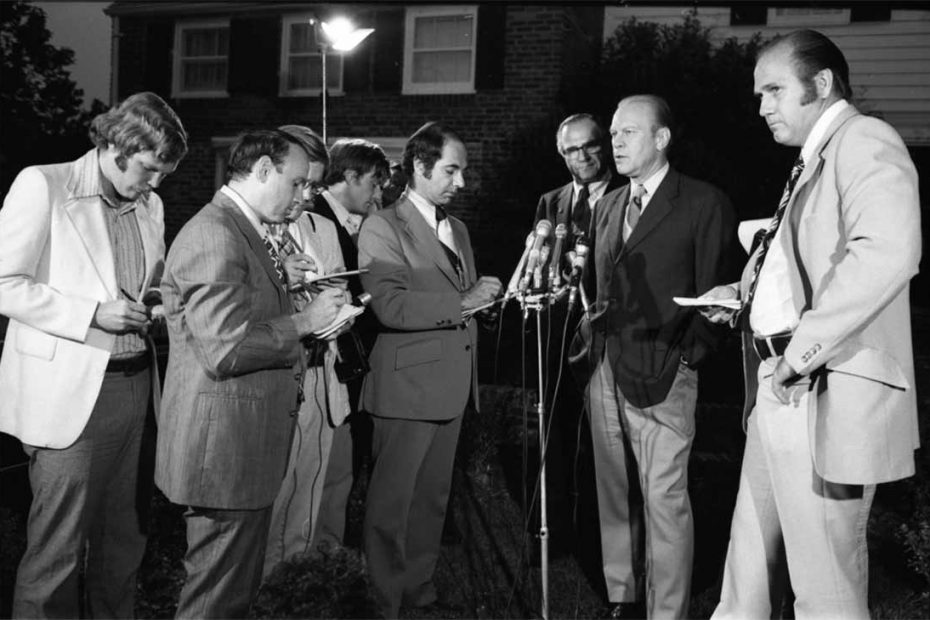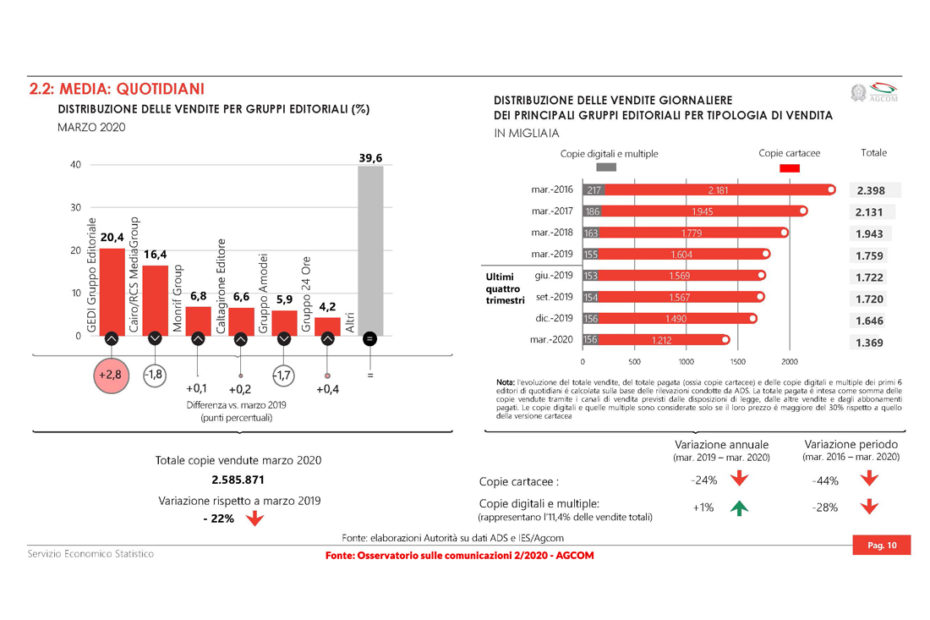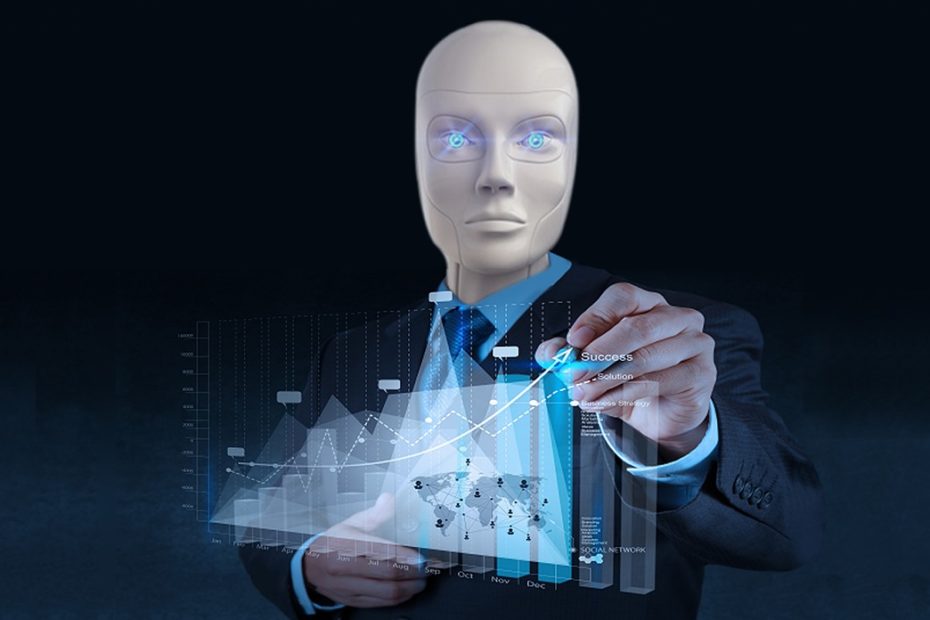L’accesso all’informazione è inclusione
“Nessuno deve essere lasciato indietro” (“no one will be left behind”) è il motto dell’Agenda ONU 2030 (siglata nel 2015) per lo sviluppo sostenibile volto a garantire l’accesso in senso lato; garantire l’accesso all’informazione è esplicitato all’interno di uno dei 17 obiettivi dell’Agenda. Garantire l’accesso all’informazione è, inoltre, la missione principale delle biblioteche e della stampa, come affermato da Glória Pérez-Salmerón, Presidente della Federazione Internazionale delle Associazioni ed istituzioni Bibliotecarie:
“Il ruolo dell’informazione nelle nostre società non è mai stato così imponente. È un facilitatore, una materia prima, una fonte di innovazione e creatività. Dare a tutti l’accesso all’informazione significa assicurare che tutti abbiano l’opportunità di imparare, crescere e prendere decisioni migliori per se stessi e per chi li circonda”.